Parco Archeologico di Pompei
Via Plinio, 26 – 80045 Pompei (Na)
Tel. 081 8575111
pa-pompei@cultura.gov.it
www.pompeiisites.org
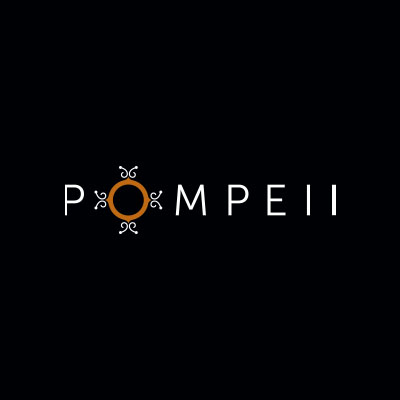 Il sito di Pompei, con la sua lunga tradizione di scavi iniziati nel 1748, ha avuto un’influenza pionieristica nella disciplina archeologica. Fin dalle sue prime scoperte divenne un luogo paradigmatico per la cultura europea e tappa essenziale del Gran Tour d’Italie, L’area archeologica si estende per 87 ettari nel cuore della città contemporanea. A pochi anni dalla sua scoperta, essa fu definita dallo scrittore Chateaubriand, che la visitò nel 1804, “una città romana conservata nella sua interezza, come se gli abitanti fossero andati via un quarto d’ora prima”.
Il sito di Pompei, con la sua lunga tradizione di scavi iniziati nel 1748, ha avuto un’influenza pionieristica nella disciplina archeologica. Fin dalle sue prime scoperte divenne un luogo paradigmatico per la cultura europea e tappa essenziale del Gran Tour d’Italie, L’area archeologica si estende per 87 ettari nel cuore della città contemporanea. A pochi anni dalla sua scoperta, essa fu definita dallo scrittore Chateaubriand, che la visitò nel 1804, “una città romana conservata nella sua interezza, come se gli abitanti fossero andati via un quarto d’ora prima”.
Il sito fornisce una testimonianza unica dell’abitare nel mondo antico, con case appartenenti ai ceti più umili fino alle grandi dimore decorate splendidamente da affreschi e mosaici. Attraverso i suoi edifici pubblici, ci restituisce inoltre uno spaccato della vita politica e amministrativa e nello stesso tempo importanti testimonianze della vita quotidiana che si svolgeva lungo le strade su cui si affacciavano botteghe e negozi locali. Dal 1748 a oggi, l’area scavata all’interno delle mura ha raggiunto l’estensione di 45 ettari. Nella città antica, sono stati portati alla luce più di 13mila ambienti, inseriti in un centinaio di isolati. Essa si configura, pertanto, come una vera e propria città, con tutte le problematiche conservative di un tessuto urbano vivo.
Dal Foro con gli edifici pubblici della città, passando per il quartiere dei teatri e fino all’Anfiteatro, Pompei offre uno spaccato unico della vita in una antica città romana con strade, piazze, spazi pubblici e case private tutti parte di un’unica realtà.
Luoghi d’eccellenza e tappe obbligate per la conoscenza del mondo antico sono le case private: la Casa del Fauno, la Casa dei Vettii, la Casa del Menandro e tutte le piccole case del ceto medio e basso che raccontano le storie comuni di chi le ha vissute fino alla tragedia; le grandi ville del territorio: la Villa dei Misteri, le ville di Oplontis e Stabiae, la piccola villa fattoria di Boscoreale; e ancora le terme, le officine tintorie, i panifici, le osterie, i lupanari, tutte le realtà quotidiane di una città di provincia dell’impero romano, rimasta congelata dalla sciagura in un giorno del 79 d.C. il nemico più spietato di Pompei è il tempo: siti e monumenti archeologici soffrono l’azione “scultorea” del tempo, che, per quanto poetica, li pone incessantemente a rischio.
Obiettivo strategico dell’azione di conservazione non può essere altro che una difesa ferrea e decisa, che combatte con tutta la sua forza per preservare ogni millimetro di materiale antico. La difesa dal degrado di strutture murarie, mosaici, intonaci e affreschi richiede una conoscenza e una capacità di prevedere con sufficiente probabilità dove si avranno nuovi attacchi. Richiede anche la lucidità di riconoscere le perdite subite in 275 anni di scavi, guardando ad esse senza sentimentalismi ma con sguardo curioso e capacità di analisi, in modo da imparare dalle esperienze del passato come proteggere meglio in futuro un patrimonio di straordinaria bellezza e complessità. Questa è la sfida che ha raccolto oggi il Parco Archeologico di Pompei, che racchiude al suo interno anche i siti di Stabiae, Oplontis, Longola e Boscoreale, in un organismo unico che costituisce la Grande Pompei.
La sfida della conservazione si esercita attraverso un’attività costante di monitoraggio e manutenzione programmata, accanto a interventi straordinari, di molteplici cantieri progettuali e operativi, in grado di produrre e di applicare con continuità e cadenza ravvicinata protocolli di manutenzione ordinaria calati sulle specificità dei singoli edifici. L’applicazione di tale sistema si è rivelato negli anni decisivo e affidabile nel prevenire e contenere l’evoluzione del degrado nel contesto fragile e complesso di Pompei, garantendo al tempo stesso il decoro e la possibilità di fruizione dei complessi edilizi e degli apparati decorativi in essi contenuti.




